Quelle che seguono sono pagine tratte da una mia ricerca, fatta per uso personale, sull’opera di questi due studiosi, personalità tra le più eminenti nella storia dei miei luoghi d’origine.
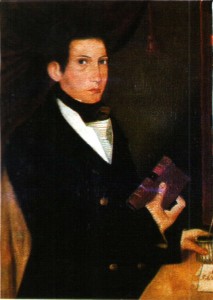 Ammetto che per un attimo, ma solo per un attimo, mi sarebbe piaciuto farne un libro, di tutte le note che ho raccolto su G.F. Pugliese, ma è stato solo un momento di debolezza: insisto nella mia distinzione, tutta personale forse, tra libro, mezzo del dare, e volume, raccoglitore fisico troppo volte privo di ‘spessore’, specie oggi che tanti, troppi personaggi, allo scoccare del terzo rigo già pensano bene di dover consegnare alle stampe e al mondo le proprie ‘fanfaluche’… Ora, poiché l’onestà, non quella abusatissima che si definisce ‘intellettuale’, ma l’onestà ‘sic et simpliciter’, quella di tutti i giorni, mi impone il rispetto della norma secondo la quale ‘unicuique suum’… spero che un’opera sull’oscuro storico di Ciro’ prima o poi qualcuno la scriva e che il sottoscritto possa leggerla.
Ammetto che per un attimo, ma solo per un attimo, mi sarebbe piaciuto farne un libro, di tutte le note che ho raccolto su G.F. Pugliese, ma è stato solo un momento di debolezza: insisto nella mia distinzione, tutta personale forse, tra libro, mezzo del dare, e volume, raccoglitore fisico troppo volte privo di ‘spessore’, specie oggi che tanti, troppi personaggi, allo scoccare del terzo rigo già pensano bene di dover consegnare alle stampe e al mondo le proprie ‘fanfaluche’… Ora, poiché l’onestà, non quella abusatissima che si definisce ‘intellettuale’, ma l’onestà ‘sic et simpliciter’, quella di tutti i giorni, mi impone il rispetto della norma secondo la quale ‘unicuique suum’… spero che un’opera sull’oscuro storico di Ciro’ prima o poi qualcuno la scriva e che il sottoscritto possa leggerla.
I paragrafi seguenti potranno sembrare mal congegnati, ed in effetti lo sono, essendo estrapolati dalla ricerca di cui dicevo poco sopra. Ad ogni modo, confidando nella pazienza del lettore:
A proposito di Giovan Francesco Pugliese mi piace premettere alla sua opera questa nota, tratta da ‘Biblioteca storica topografica delle Calabrie’, dell’Avvocato Niccola (sic) Falcone da Verzino, Napoli 1846.
‘La patria di questo benemerito e dotto scrittore è Cirò di cui ora è unica attuale illustrazione. Egli professa giurisprudenza, e benché di proposito non la eserciti, pure adopera la sua dottrina dando consiglio a coloro che in difficili affari ne lo richieggono, rendendosi in questo modo utile alla sua patria, ed ai paesi circonvicini. Egli nel 1826 pei tipi del Tiziano in Napoli rese di pubblica ragione un ‘Compendio sulle attribuzioni de’ regi Giudici’: lavoro molto utile per i forensi. Ha scritto la storia di Cirò, della quale fa sperarne la pubblicazione. Io mi auguro ciò voglia verificarsi pria che io riduca a termine la stampa di questo mio lavoro, perché abbia l’occasione di esporre un’opera che sarà certo di molto merito e gradita ai cultori della storia. E se il sig. Pugliese volesse ancor più soddisfare i voti di tutti, pubblicherebbe il suo ‘Itinerario da Squillace a Napoli, lavoro senza dubbio dottissimo, precisamente in fatto di archeologia. Possano dunque tai voti essere esauditi, ed io ne porgo all’autore le più vive preghiere.’
Scrittura e grafica ai tempi di G.F. Pugliese
La prosa, la ‘scrittura’, del Pugliese, differiscono dalla attuale anche nella loro ‘resa grafica’, per così dire: delle occorrenze più evidenti rimarco l’uso dei due punti in luogo delle virgole e delle iniziali maiuscole nel corpo del periodo. Anche nella coniugazione verbale vi sono degli esiti che attualmente risultano come ‘errori’: non ho avuto l’ardire di applicare la grammatica e l’ortografia correnti, ovvero di correggere od emendare il testo originale, poiché ritengo che tale originalità vada sempre e comunque, almeno in certa misura, rispettata, e che l’onere, ma anche il piacere, dell’interpretazione rimangano a carico del ‘lettore moderno’. Non si meravigli, quindi, il lettore di imbattersi in termini strettamente legati al dialetto del luogo, come ad esempio un ‘cati’ per ‘secchi’, come pure di termini che pur ripetendosi a breve o brevissima distanza l’uno dall’altro compaiono sotto forme differenti e in certo qual modo contraddittorie. Di fronte alla importanza documentale dell’opera, quelli appena mossi sono rilievi ininfluenti, ché l’opera di Giovan Francesco Pugliese è di primaria importanza per la storiografia non solo di Cirò, ma anche della Calabria e del Sud più in generale, divenendo fonte cui attingere per tutti gli storiografi, locali e non, improvvisati o meno che siano; a maggior ragione quando si parla di territori le cui ‘memorie’ – leggi soprattutto archivi – sono stati spesso, e non a caso, saccheggiati o distrutti, fatti oggetto di ‘cesìna’, come forse direbbe il Nostro.
********************
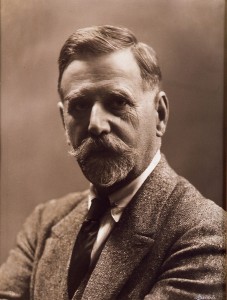 Occorrerà anche premettere, forse, che per gli abitanti di Cirò e Cirò Marina è ovvio, scontato, almeno il sapere che nei pressi di Punta Alice esistette una colonia greca chiamata Krimisa o Cremissa, dalla quale sarebbe poi sorta Cirò, e infine Cirò Marina. Questo è, nell’immaginario collettivo ‘locale’, supportato dagli scavi dell’archeologo trentino Paolo Orsi, grande e ostinato nella sua ricerca della Krimisa magnogreca che le paludi, l’incuria, i saccheggi, avevano cancellato alla vista degli uomini. L’impegno di Paolo Orsi fu premiato nel 1924 con il ritorno alla luce dei resti della città-santuario di Krimisa e del suo Templum Apollinis.
Occorrerà anche premettere, forse, che per gli abitanti di Cirò e Cirò Marina è ovvio, scontato, almeno il sapere che nei pressi di Punta Alice esistette una colonia greca chiamata Krimisa o Cremissa, dalla quale sarebbe poi sorta Cirò, e infine Cirò Marina. Questo è, nell’immaginario collettivo ‘locale’, supportato dagli scavi dell’archeologo trentino Paolo Orsi, grande e ostinato nella sua ricerca della Krimisa magnogreca che le paludi, l’incuria, i saccheggi, avevano cancellato alla vista degli uomini. L’impegno di Paolo Orsi fu premiato nel 1924 con il ritorno alla luce dei resti della città-santuario di Krimisa e del suo Templum Apollinis.
Al tempo di Giovan Francesco Pugliese la situazione era alquanto diversa: i ritrovamenti archeologici si riducevano a ben poca cosa, e l’esistenza della colonia greca si basava soprattutto su fonti letterarie, librastiche più in generale… Verrebbe da dire che si trattava quasi più di un atto di fede nella storiografia che di verità storica accertata, scientificamente provata.
Non a caso l’autore, già dalle prime battute della ‘Descrizione’, parla, quasi chiedendo venia, di una sorta di ricorso alle origini molto, forse troppo, favolose e favolistiche, non solo della sua amata e sognata Krimisa, ma di tutte le altre località della Magna Grecia, nel ricordo e nel richiamo di un passato grandioso che non trovava – e non trova – riscontro alcuno né ai tempi del Pugliese, né in quelli attuali.
Parlo di quella Magna Grecia che faceva dire all’altro cirotano Luigi Siciliani (1881-1925), il traduttore dei poeti erotici dell’antologia palatina:
Hera ed Apollo non sono signori di templi sui flutti
Dileguarono insieme per sempre gli umani e gli iddìi.
Cupo squallore, miseria profonda ci aduggia da allora!
Noi che chiamati fummo greci, ma greci più grandi,
noi, ora siamo negletti in solitario abbandono.
(Capo Crimisa, in ‘Sogni pagani’, poi in ‘L’altare del Fauno’).
Versi superbi e precisi, purtroppo, dacché quella miseria che ci aduggia non è mai scemata, tutt’altro, e anzi quel ‘solitario abbandono’ sembra essere destinato a divenire totale e desolante, e sempre più dolente nel far sentire la distanza, l’abisso che separa quei greci addirittura più grandi dai loro dèi fuggitivi (e l’appellativo ‘Aleo’, anche questo significato sembra adombrare).
Ed ecco cosa dice, invece, Paolo Orsi a proposito di Pugliese, peccando forse a sua volta di superficialità o di un distacco professorale un po’ troppo insistito:
‘’Chi ha tenuta sempre e tenacemente viva la tradizione che il tempio di Apollo sorgesse alla Mesola di S. Paolo è stato un vecchio cronista di Cirò, G. F. Pugliesi (sic!, n.d.r.), ‘Descrizione ed istorica narrazione di Cirò’ (Napoli, 1849), il quale accolse vecchie secolari tradizioni paesane, nonché fanfaluche, senza criticamente vagliare il verosimile dal fantastico. Così a pag. 19 egli asserisce che nel giardino dell’ex barone ora proprietà Sabatini presso Cirò stazione, siansi rinvenuti nel 1440 i ruderi di un tempio di Venere, con 4 grandi candelabri di ferro (sic). Per lui il tempio di Apollo sorgeva nella Mesola di S. Pietro e Paolo, in mezzo al bosco di Ardetto, cinto d’inverno dal lago delle Vurghe o Vulghe, pozzetti molto profondi… Il luogo era adatto per un piccolo porto interno, la cui costruzione fu vagheggiata ai tempi di Carlo III, ma poi abbandonata. Preziosa la notizia data a pag. 17, se non fosse essa pure inquinata di dati fantastici, sulla cui attendibilità è superfluo discutere: «I ruderi di questo tempio hanno esistito fino a’ giorni miei, ed io li ho più volte visitati, ammirando le volte del sotterraneo, che ancor muggiva al muggito delle onde; ma ora quasi tutto è sparito, perché spianato per farne i materiali alle recenti fabbriche di casine e casette che abbelliscono le nostre marine». Le varie frottole ed invenzioni fantastiche che infiorano l’esposizione del Pugliesi, come quella dei sotterranei del tempio mugghianti, ci aveva fatto ritenere non meritevole di fede anche la parte veridica del suo racconto. Oserei persino sospettare che il Pugliesi avesse soltanto accolta una vecchia tradizione popolare, inventando il resto. Sta però il fatto che il vecchio lanternaio di Punta Alice, che visse per oltre 30 anni sul luogo, battendo come cacciatore il terreno palmo a palmo, mai ebbe sentore né della tradizione né delle mine, perché, è evidente, anche la tradizione era ormai spenta nella memoria dei contemporanei.
Faccio grazia al lettore della ricerca, direi genealogica, sul nome di Cirò (pag. 27) che nelle carte medioevali sarebbesi denominato Ypsicron (gioverebbe un controllo) donde Psigrò, Sigrò, Zirò, Cirò. Qua egli confonde Paternum presso Cariati con Cirò, rivendicando a questo, ed a torto, una sede vescovile; ma su ciò tagliano corto gli itinerari. Utile invece trovo la notizia che la città medievale aveva quattro porte; in quella di Cacovìa, si conservava ancora in posto una epigrafe, a tutti sfuggita che parmi bizantina (pag. 35); metterebbe conto di rintracciare codesto titolo.’’
(da Paolo Orsi, ‘Templum Apollinis Alaei ad Krimisa Promontorium’, Società Magna Grecia, 1933).
Per quanto ho potuto ricavare ed intendere dalle mie letture non specialistiche, colgo nelle parole di Paolo Orsi, al quale saremo comunque eternamente riconoscenti, un atteggiamento che rasenta il disprezzo, nei confronti del Pugliese, e non solo verso di lui, dacché mi sembra che questo suo atteggiamento di superiorità non solo ‘culturale’ ma anche di ‘differenti origini’, traspaia qua e là nel ‘Templum Apollinis…’ anche nei confronti degli abitanti di Cirò, mitigato da qualche doverosa concessione sparsa sia nei riguardi del ‘povero cronista locale’ sia verso gli ‘indigeni’, intesi come ‘naturali del luogo’.
Di Paolo Orsi, soprintendente alquanto potente, parla anche Carmine Abate nel suo ‘La collina del vento’, con un atteggiamento e una disposizione d’animo forse troppo positivi, a mio modesto parere, ma parlando di opera narrativa e poetica è piena facoltà dello scrittore esaltare gli aspetti che meglio ritiene di dover sottolineare. Per quanto riguarda G.F. Pugliese vorrei dire che la sua opera avrebbe meritato miglior sorte e di non essere solo semplicemente saccheggiata da autoproclamati scrittori di storia locale. Certo, nella ‘Descrizione…’ vi sono degli aspetti e delle affermazioni un po’ fantasiose, o, per dirla alla paesana ‘arranciatizzi’: questo me lo spiego con le difficoltà che il Nostro avrà dovuto affrontare nel reperire testi e nell’accedere alle fonti della sua opera storiografica. Ad oggi, 2013, posso dire, senza tema di smentite, che il Pugliese è riuscito ad affrontare argomenti di vastissima portata, dall’agricoltura alla scienza medica, dalle glorie locali (Lilio, Casoppero, Astorino) alla storia a lui coeva, con tanto di denuncia sociale, e contemperando la vastità delle proprie vedute con il panorama disarmante che aveva di fronte. Per questo dico che Paolo Orsi avrebbe dovuto meditare di più e meglio, prima di criticare quell’oscuro cronista che tale non doveva essere, avendo messo a disposizione il proprio sapere non solo giuridico, ma anche di civiltà, al servizio della Nazione – si legga Regno delle Due Sicilie – e della comunità cirotana, impegnandosi nel governo della ‘università’ di Cirò.
Vorrei sottolineare un altro aspetto che mi è sembrato di cogliere nella ‘Descrizione…’: un duplice piano di lettura, l’uno discorsivo, narrativo, l’altro più ‘cogente’, profondo, impregnato della cultura non solo giuridica dell’autore, quando costringe il lettore – oggi – a dover consultare internet per sapere di cosa egli stia parlando, ad esempio, quando disquisisce di sistema feudale o di tecniche delle coltivazioni agricole, auspicandone il rinnovamento .
…Ma del resto, dell’oscuro storico locale la ‘città’ di Cirò Marina non ha ritenuto di trattenere traccia dedicandogli una via, una piazzetta, una targa… o permeglio dire: nello stradario cittadino non ne ho trovato traccia. Naturalmente posso sbagliarmi, ma se avessi dovuto scegliere tra dedicare una via a Cronin (esiste), quello de ‘Le stelle stanno a guardare’, o a G. F. Pugliese, che ha scritto la nostra storia, o che perlomeno ci ha provato… io avrei scelto il secondo, e ci avrei messo anche una targa a ricordo della sua opera.
Ora chiudo davvero, rivolgendomi ai discendenti di G. F. Pugliese, sempre ammettendo che leggano questa mia lettera: ad un certo punto, il loro antenato parla della intenzione di stilare una grammatica o un lessico cirotano, del quale non trovo altra traccia… a loro vorrei domandare se esiste un archivio, un carteggio o qualcosa di simile nella ‘eredità’ di G. F. Pugliese… sarebbe bellissimo, cioè no: sarebbe interessantissimo.
Cataldo Antonio Amoruso, da Cirò Scalo, abitante a Piacenza.







Uno dei temi più insistiti della politica attuale è quello della tassazione della ‘prima casa’… è cambiato qualcosa? Bisognerebbe dirlo a qualche politicante di oggi, facendo notare che lo scritto è della prima metà del XIX secolo. L’oscuro storico locale, secondo me, ci vedeva benissimo, anzi… aveva un perfetto campo visivo! E diceva così, circa due secoli fa:
”Lodevole il voto espresso dal signor Scotti di minorarsi la Contribuzione su’ fondi rustici, ma non meno santo sarebbe l’altro dell’abolizione totale sulla domiciliaria. Nella Capitale (parla di Napoli) le case, ed i palazzi sono la migliore proprietà produttiva; nelle Provincie sono la più sventurata, ed aggravante. Le sole case in locazione dovrebbero tassarsi sul sistema dell’antico catasto, ed esentarne l’abitazione della famiglia del Proprietario.”
Giovan Francesco Pugliese, ”Descrizione ed istorica narrazione dell’origine… di Cirò”, vol. II, cap. VIII, Napoli 1849.
Ho aggiunto questa ‘postilla minore’ giusto per avere un riferimento concreto circa la capacità di analisi di GF Pugliese, che va ben oltre questa nota in calce.
C. A. Amoruso.
Plaudo alla felicissima iniziativa di Cataldo Antonio Amoruso e alla disponibilità di Carolina Pugliese. Cirò possiede un grande patrimonio storico, e con Lilio, Astorino e Adorisio anche scientifico, da rivalutare e divulgare. La passione ed il talento di Cataldo ci porteranno a riscoprire la figura di G.F. Pugliese strappandola alla “minorità” a cui un colpevole e oserei dire forse interessato oblio l’ha confinata per quasi due secoli.
Francesco Vizza
Le parole di Carolina Pugliese e di Francesco Vizza, cioè di due ‘illustrazioni’, ovvero personaggi che danno lustro al ‘cirotano’, – come direbbe il Niccola Falcone che ho citato nella ‘lettera’- sono per me uno sprone ineludibile e un riconoscimento graditissimo; spero con il loro aiuto di riuscire in quella che per me, semplice dilettante,potrebbe essere una impresa davvero ardua. Li ringrazio entrambi per la loro rara generosità.
mi complimento con lei per l’interessante e approfondito articolo. La ringrazio anche di avermi fatto conoscere qualcosa di piú del mio avo. In quanto discendente di Pugliese accolgo volentieri la sua richiesta e, per quanto mi é possibile, le metto a disposizione tutto il materiale in mio possesso. Ancora grazie!
La ringrazio di cuore, gentilissima signora Carolina Pugliese, con la speranza di poter fare buon uso del materiale che vorrà mettere a mia disposizione. Mi auguro di meritare la stima che Lei sta esprimendo nei miei confronti. Modestamente, ritengo che l’opera del Suo antenato meriti molta più attenzione di quanta ne abbia avuta, anche tenendo presenti le condizioni storiche, di certo non facili, in cui essa vide la luce. Parlo di virtù misconosciute, quelle di GF Pugliese, e di crediti millantati, quelli di quanti ne hanno sfruttato l’opera senza svolgere una seria analisi storica: anche in questo caso credo si possa dire ‘Roccu fatiga e spaturnatu mancia’…
Grazie ancora, e a presto, spero.
Cataldo Ant. Amoruso.
Concordo con Ninetto Russo: anch’io ammiro profondamente quelli come GF Pugliese e Paolo Orsi… Jean Berard, F. Lenormant e tantissimi altri.
C. A. Amoruso.
Ammiro sinceramente,chi si sacrifica, in dotte ricerche e studi,per farci conoscere le nostre origini di discendenti della MAGNA GRECIA.
Ninetto Russo